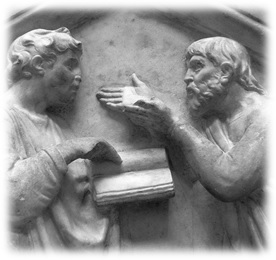
Quali sono i meccanismi logici che guidano le decisioni di un giudice? Quali i modelli di ragionamento giudiziale applicati nel processo? Partendo dal tradizionale schema del sillogismo giudiziale, il contributo analizza criticamente i limiti della logica deduttiva, valorizzando il ruolo delle massime d’esperienza e dell’apporto scientifico nella formazione del convincimento giudiziario. L’autore mette in luce come, nel contesto processuale, la certezza non sia mai assoluta e la valutazione della prova richieda equilibrio tra rigore metodologico e apertura alle molteplici sfaccettature della realtà. Una lettura imprescindibile per chi vuole addentrarsi nei modelli di ragionamento, tra norme, fatti e interpretazioni.
IL SILLOGISMO GIUDIZIALE
In uno scritto dell’Ing. Cipriani (clicca qui per leggere l’intervento), dal quale ho tratto spunto, viene richiamata la necessità di un aggiornamento costante per i consulenti, in relazioni ad argomenti che potrebbero apparire collaterali, quali l’argomentazione dialettico-processuale e dibattimentale, nonché l’aspetto giuridico e processuale. Il tutto per la realizzazione di una figura tecnica «che coscientemente operi nel processo»
È da qui che intendo partire e rammentare ciò che Alessandro Giuliani afferma sull’istituzione processo:
«Il processo è una delle più complesse istituzioni sociali: la sua struttura utilizza – in una varietà di combinazioni – elementi logici (verità dei fatti), etici (la doverosità della verità), politico istituzionali (rapporto tra legislatore e giudice).
Il ragionamento giudiziale
Il sillogismo giudiziale, nel suo significato maggiormente condiviso, individua la logica posta a fondamento delle decisioni giudiziali, e quindi lo schema inferenziale che permette di render conto della natura logico-deduttiva dell’applicazione giudiziale del diritto.
Inferenza: nella logica l’inferenza (dal latino in ferre cioè portare dentro) è il processo attraverso il quale da una proposizione assunta come vera si passa a una seconda proposizione la cui verità è derivata dal contenuto della prima secondo opportune regole di inferenza
La norma richiamata dal dispositivo di un provvedimento giudiziale rappresenta, nella struttura sillogistica, il risultato di un’inferenza logica in cui l’enunciato del dato giuridico e l’enunciato del dato fattuale stanno, rispettivamente, per la premessa maggiore e per la premessa minore.
Nonostante parte della dottrina sia fermamente convinta del superamento della logica deduttiva di matrice sillogistica, tale struttura continua ad avere consenso a livello giurisprudenziale.
Concezione logico-deduttiva delle decisioni giudiziali
Gli elementi costitutivi di una decisione giudiziale possono sinteticamente limitati a tre:
- accertamento dei fatti oggetto della vertenza;
- individuazione della norma generale alla cui fattispecie sono riconducibili i fatti oggetto della vertenza;
- soluzione della vicenda attraverso il dispositivo (applicando la norma giuridica ritenuta risolutiva)
Quindi:
- la premessa maggiore è rappresentata della norma generale alla cui fattispecie possono essere sussunti i fatti oggetto della controversia;
- la premessa minore, (o premessa fattuale) è rappresentata dai fatti oggetto della controversia;
- la conclusione è invece espressa dal dispositivo ovvero dalla norma con cui l’organo decisionale pone termini alla controversia.
Sarebbe questa, la struttura di quello che convenzionalmente viene denominato “sillogismo giudiziale”, la struttura, cioè, della decisione giudiziale concepita come un’inferenza logico-deduttiva.
Per esemplificare, si può rammentare l’esempio più volte proposto da Kelsen:
Premessa maggiore: Tutti i ladri devono essere puniti
Premessa minore: Schulze è un ladro
Conclusione: Schulze deve essere punito.
Non possono peraltro negarsi, come sottolineati dalla dottrina maggioritaria, i principali rilievi critici, alla logica deduttiva del sillogismo giudiziario, rappresentati da:
- problemi concernenti la formulazione della premessa maggiore o giuridica;
- problemi concernenti la formulazione della premessa minore (o fattuale);
- problemi concernenti la possibilità di operare inferenze logiche fra enunciati che esprimono norme giuridiche.
Va comunque precisato che lo schema logico principalmente utilizzato nella redazione delle sentenze è proprio quello sillogistico.
Come noto, caratteristica precipua del processo, e quindi della logica ad esso sottostante, è che il giudice si avvale, come direbbe Habermas, di un agire e di un sapere comunicativo.
Lo studio delle nuove teorie della retorica e della argomentazione evidenziano come centrale sia l’affidamento nei confronti della ragione pratica; quindi, grande diffidenza verso ciò che appare giusto ad un solo individuo, e quindi ciò significa una condivisione delle conoscenze.
Ecco, per esempio, il valore euristico del contradditorio come acquisizione del dato probatorio.
Procedimento euristico: si definisce procedimento euristico, un metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue un chiaro percorso, ma che si affida all’intuito e allo stato temporaneo delle circostanze, al fine di generare nuova conoscenza. È opposto al procedimento algoritmico.)
È opinione comune quella secondo la quale il processo argomentativo è intrinsecamente complesso, ragione per la quale non può essere ricondotto, come evidenzia la miglior dottrina e come sopra abbia anticipato, esclusivamente ad un ambito formalistico o sillogistico.
In sostanza, come evidenzia Ubertis, il ragionamento del giudice (o forse sarebbe opportuno dire il miglior ragionamento del Giudice) è, o dovrebbe essere (ndr), intessuto di elementi non assimilabili ad una sola categoria: a seconda dei casi, essi sono riconducibili a schemi logico formali, ma anche topici (schemi argomentativi correlati alla tesi da dimostrare) o valutativi (principio del libero convincimento del giudice) o retorici.
Per quanto riguarda l’ambito del nostro tema, riveste particolare importanza, l’indagine sugli strumenti/metodi usati dal giudice attraverso i quali si arriva alla conoscenza (giudiziaria) dei fatti oggetto di giudizio (ci limitiamo a due elementi)
Le massime di esperienza rappresentano i principali strumenti conoscitivi utilizzati dal Giudice nella sua attività di ricostruzione del fatto. Lo stesso art 192 comma 1 c.p.p. chiarisce come nella motivazione della pronuncia debba comparire «l’indicazione dei criteri adottati» leggasi massime di esperienza utilizzate per valutare il fondamento della prova.
La massima di esperienza è una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi, essa è ricavabile da casi simili al fatto noto.
Ubertis rammenta come la funzione tipica delle massime d’esperienza sia dunque quella topico – euristica: esse consentono il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute di particolare rilievo per l’indagine in corso, e forniscono al giudice una serie di topoi (elementi) utilizzabili quali premesse per la soluzione di problemi che si trova ad affrontare.
Ma attenzione: QUESTO SIGNIFICA CHE IL «GENERALMENTE SUCCEDE QUESTO, NON SIGNIFICA CHE IL QUEL CASO SIA EFFETTIVAMENTE SUCCESSO»!
Leggi scientifiche
Le leggi scientifiche non possono essere disapplicate nel corso dello svolgimento processuale, in quanto si tratta di conoscenze universali, pena l’incomunicabilità delle decisioni giudiziali.
Nelle materie che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche, il giudice deve affidarsi a persone che hanno conoscenze specialistiche in quella determinata disciplina.
Costoro potranno indicare quale legge scientifica, o della natura, è applicabile ad un determinato fatto, al fine di individuarne le cause.
La legge scientifica dà maggiore sicurezza, ma restano comunque margini di opinabilità, poiché si tratta di:
- scegliere la legge scientifica che deve essere applicata al caso di specie;
- valutare in quale modo deve essere applicata;
- individuare i fatti ai quali applicarla.
Ma sarà poi il giudice, peritus peritorum, a dover effettuare una valutazione del contenuto della perizia.
Quindi:
- per la valutazione probatoria, in ragione di quanto asserito sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (C. Cost. sent. 8/09/1981 n 96 ; C. Cost 16/04/1998 n.114), si ricava che, l’incertezza cognitiva sul piano scientifico diventa motivo di irragionevolezza costituzionalmente rilevabile soltanto quando l’interprete non abbia alcuna possibilità alternativa di pervenire a soluzioni ermeneutiche ragionevoli dei casi concreti;
Sui giudizi di fatto nel sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi (in studi in onore di Mario Romano, I, Napoli, 2011, p 206), l’ordinamento giuridico non può astrarre dagli esiti della ricerca scientifica.
In sostanza il giudizio di «verità» al quale si perviene attraverso l’istruzione probatoria va formulato anche in base allo stato delle conoscenze al momento della emanazione della sentenza
Più specificamente è necessario soffermare la nostra attenzione sul rapporto tra conoscenze scientifiche e fenomeno probatorio.
In particolare, in relazione all’acquisizione probatoria, come evidenzia Ubertis, esiste sempre un collegamento con l’esperienza scientifica, per la formulazione dei giudizi di verosimiglianza dell’oggetto di prova e dei giudizi di rilevanza dell’esperimento probatorio.
- Verosimiglianza: il giudice deve verificare se quanto asserito «non sia in contrasto con l’insieme delle leggi logiche e scientifiche non probabilistiche, o detto altrimenti, se possa essere accaduto secondo quello che è il patrimonio epistemologico (ovvero storicamente determinato al momento del giudizio di ammissibilità probatoria (es: non vi sia il richiamo ad eventi soprannaturali) (G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013, pag. 87-88)
- Rilevanza: del mezzo o fonte di prova, esige che l’elemento di cui si chiede l’introduzione nel processo sia l’esito controllabile di un procedimento assuntivo «in maniera conforme ai parametri epistemologici storicamente dati» (G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013).
Nella prova scientifica possono essere ricondotte sia « i mezzi di prova nei quali si usa uno strumento scientifico-tecnico che richiede specifiche competenze e quindi l’intervento di un esperto per svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni » (art. 220 comma 1 c.p.p.) ordinariamente attraverso l’istituto della perizia, sia altri mezzi di prova, quali ad esempio gli esperimenti giudiziali disposti, ai sensi dell’art. 218 comma 1 c.p.p., per « accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo (cfr Ubertis Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.3, 2016, pag. 1192)
Ammissione o meno della prova scientifica
La prova deve essere:
- Pertinente: (cioè attinente alla regiudicanda e implicante una valutazione a «carattere ipotetico nel senso che dà per provati i fatti, di cui si chiede la prova, e si concentra nel controllare se sarebbero idonei a produrre le conseguenze giuridiche vagheggiate dalle parti»;
- Rilevante: nelle diverse prospettive della non ridondanza (ossia, non possono essere inutilmente volti a conseguire la superflua ripetizione dell’esito di altri) e dell’idoneità contenutistica (perché in grado di condurre alla conferma o alla smentita dell’affermazione probatoria cui si riferiscano);
- Idonea: esigendosi, dal punto di vista epistemologico, che concernano attività e risultati sia controllabili che razionalmente giustificabili sul fondamento dei parametri epistemologici storicamente dati. (cfr Ubertis Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.3, 2016, pag. 1192);
In sostanza il percorso argomentativo del giudice deve indicare in autonomia, le ragioni per le quali quella soluzione e non altre si rivela conforme ai presupposti normativi dettati dall’ordinamento giudiziario.
Motivo per il quale risulta molto complesso pervenire ad una «riduzione ad uno» dei modelli di ragionamento giudiziale, considerati al di là del tema della prova, sul quale vi sono moltissimi studi di filosofia o teoria del diritto.
Per rendersi conto di ciò, è sufficiente pensare al secolare dibattito circa il fondamento e l’accertamento del nesso di causa, fino ad arrivare al prevalente criterio oggi utilizzato della così detta causalità scientifica.
In sostanza si viene ad affermare un metodo analitico deduttivo, che parta da una ipotesi ampiamente probabile, ispirata ad una regola generale, e che poi venga asseverata da controlli successivi anche sperimentali.
In tema di valutazione delle prove, la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa la decisione, ha l’onere di criticare specificamente l’esito della prova, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal perito e convalidata dal giudice di merito un’altra e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l’insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio. (Fattispecie relativa alla testimonianza resa da minore vittima di abusi sessuali, ritenuta rispondente ai criteri di validazione richiesti dal cd. Statement Validity Analysis, attraverso il metodo denominato CBCA). (Rigetta, App. Sez. Min. Palermo, 14/05/2014) (Cassazione penale sez. III 17 novembre 2015 n. 15891).
Nella nota sentenza “Franzese” si legge: nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistere sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso si realizza solo se si accerti che ipotizzando come dovuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’inferenza di decorsi causali alternativi l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva»
Il giudizio di alta probabilità logica non definisce il nesso causale in sé e per sé, ma piuttosto il criterio con il quale procedere all’accertamento probatorio di tale nesso, il quale, diversamente da quanto accade per l’accertamento di ogni altro elemento costitutivo del reato, deve consentire di fondare, all’esito di un completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibili, un convincimento sul punto, dotato di un elevato grado di credibilità razionale (Cassazione penale sez. IV 12 febbraio 2014 n. 9695).
Focus sulla valutazione probatoria in ambito penale
Lo schema di ragionamento di tipo sillogistico
- «In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. (Nell’affermare il principio, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio).» (Cassazione penale, sez. V, 21/02/2014, n. 16397).
La giurisprudenza di legittimità definisce l’indizio quale «fatto certo dal quale, per interferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si arriva a dimostrare il fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario» e individua nella sua connaturata ambiguità il tratto che lo distingue dalla prova, essendo il fatto indiziante, di norma, significativo di una pluralità di fatti non noti (Sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Musumeci, in C.E.D. Cass., n. 191230).
Sulla stessa linea interpretativa la sentenza di cui sopra chiarisce che mentre la prova, ricollegandosi in via diretta al fatto oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l’indizio, considerato di per sé, «fornisce nulla di più di una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo che può avere diverse sfaccettature» (in senso analogo v. Cassazione Penale Sez. I, 28 giugno 1999, n. 9151,ivi, n. 213922; Sez. I, 29 maggio 1987,ivi, n. 176834).
Ecco dunque che, se la prova determina il venire in rilievo di un «un profilo valutativo di credibilità», l’indizio, indice di “diverse verità”, impone al giudice di condurre, dopo un previo esame di credibilità, una scelta, sulla base di un’indagine di natura probabilistica, tra vari possibili significati che il fatto indiziante può assumere
Il giudice, a fronte di una pluralità di indizi, deve procedere, nel rispetto dei parametri suggeriti dal comma 2 dell’art. 192 c.p.p., ad «un esame parcellare di ciascuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione, che è inversamente proporzionale al numero di collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto, nonché la gravità, apprezzata con i medesimi criteri; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via esser desunta l’esistenza o, per converso, l’inesistenza di un fatto» (Cassazione penale Sez. VI, 30 maggio 1994, n. 9916,ivi, n. 199451).
Conclusioni
Alla luce delle articolate dinamiche processuali e dell’essenziale funzione ricoperta nel procedimento giudiziario, il consulente tecnico è chiamato a operare con piena consapevolezza del proprio ruolo e delle norme che regolano il processo. Solo attraverso una costante formazione e un aggiornamento rigoroso, anche su tematiche apparentemente accessorie quali l’argomentazione dialettica e l’approfondimento giuridico-procedurale, il consulente può garantire un apporto tecnico realmente cosciente, autonomo e conforme ai canoni dell’ordinamento. Tale approccio non solo valorizza la funzione tecnica, ma assicura il rispetto dei principi di trasparenza, competenza e responsabilità, imprescindibili per l’efficace contributo all’accertamento dei fatti e alla corretta amministrazione della giustizia.
Foro di Verona

